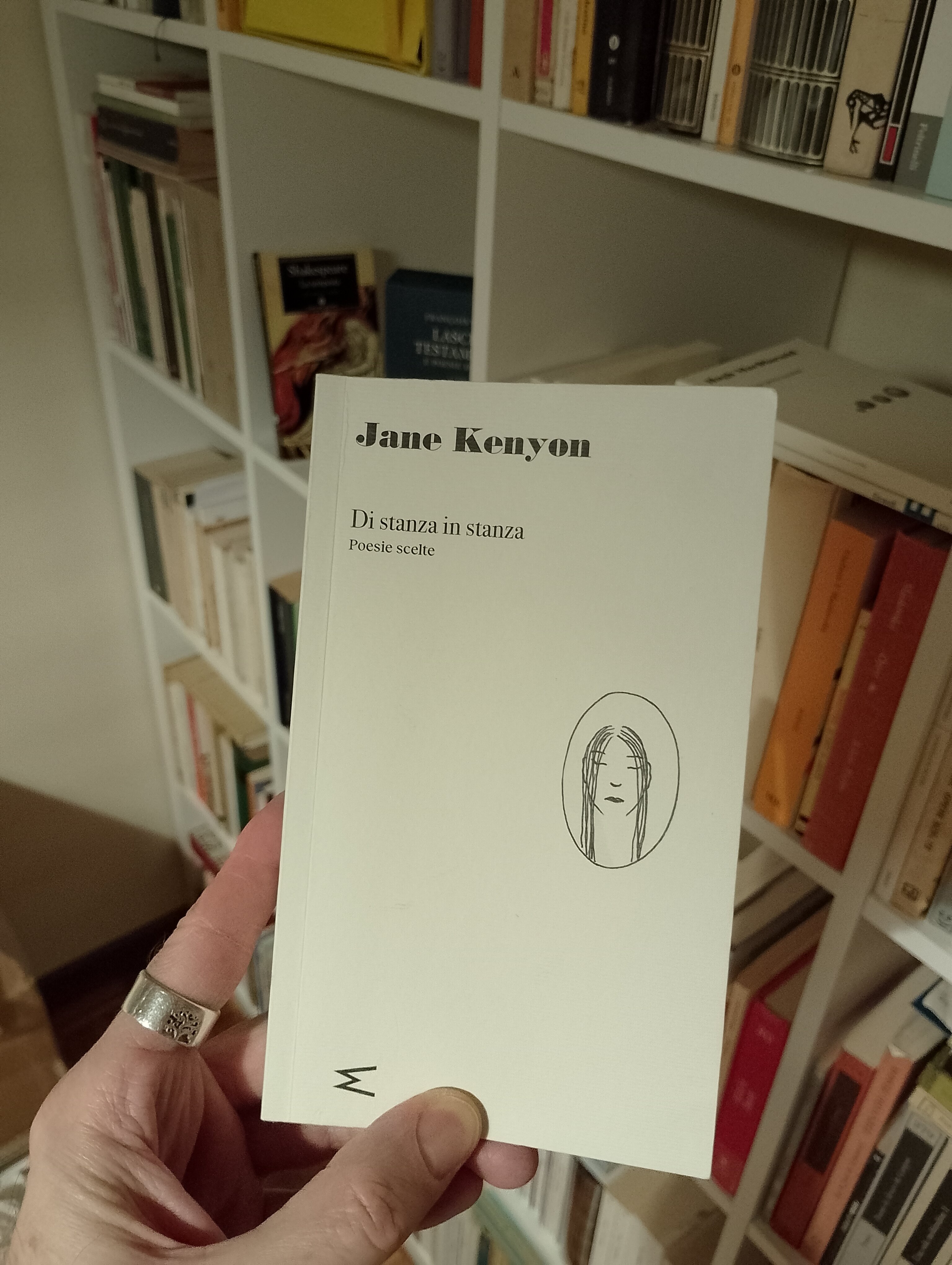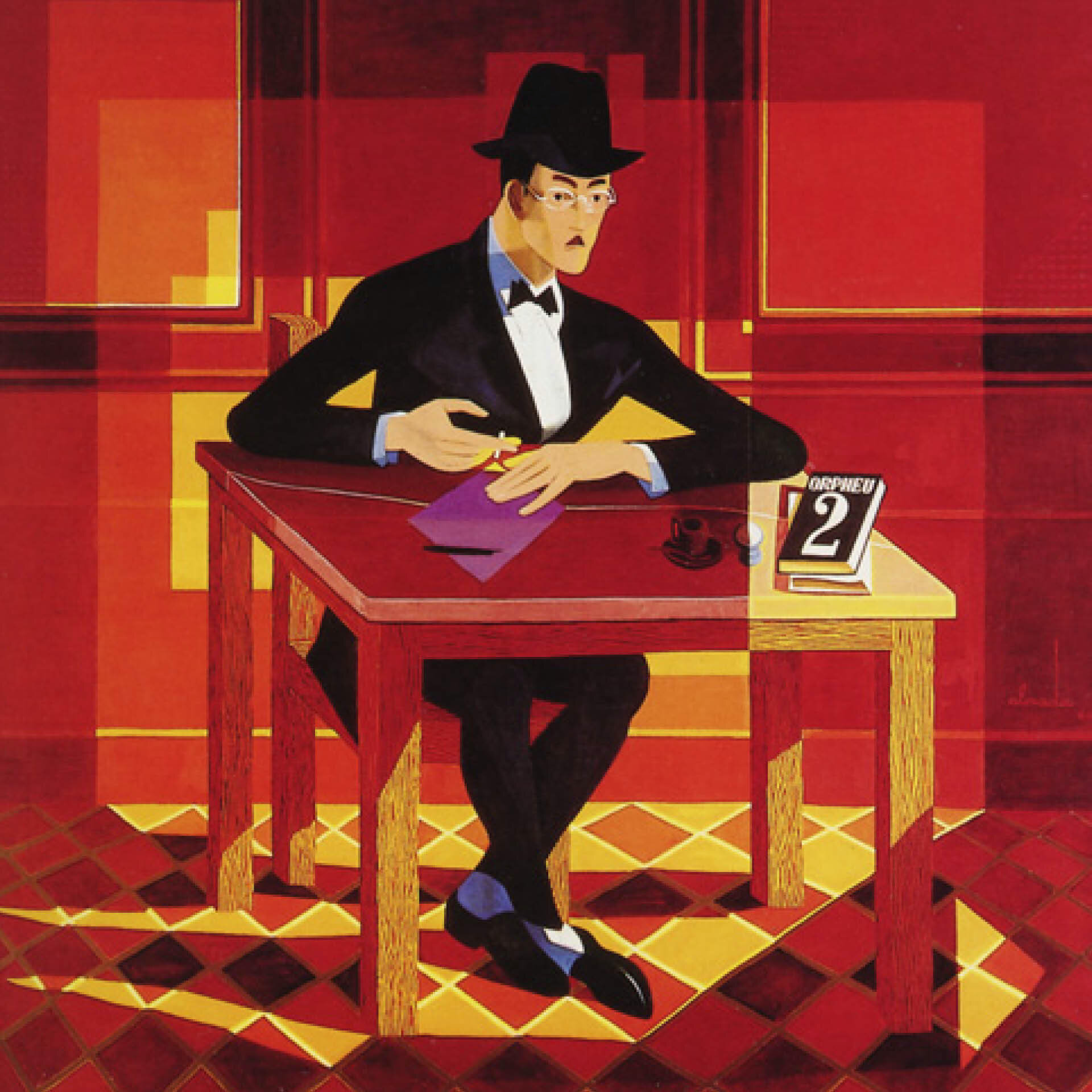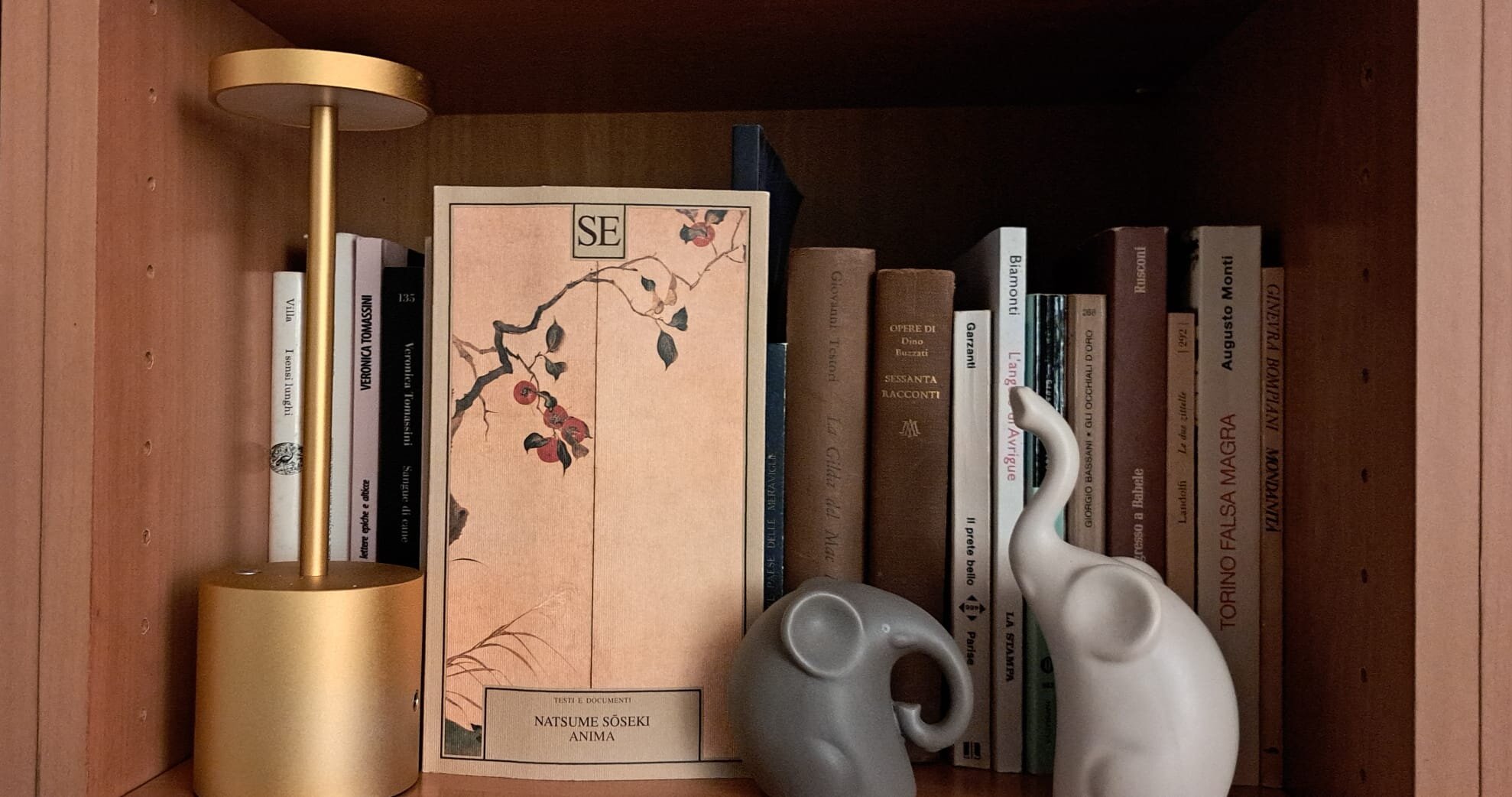VALERIA DI FELICE
Il giallo del semaforo, Società Editrice Fiorentina, Firenze, 2025 (collana Pasifae diretta da Mario Fresa)
Si può dire che la presente raccolta di poesie ha un titolo nettamente e doppiamente allusivo; un titolo che è un segno d’arresto, di sospensione e di ripartenza, ma non nell’ambito di una decisionalità meramente soggettiva, ma in quello di un obbligo oggettivo, di un segnale che riguarda tutti coloro che si trovano nella stessa condizione dinamica e nello stesso doveroso intento: un segnale, tuttavia, che non annulla la libertà individuale, ma la disciplina, indicando un comportamento preciso: “un’ombra intermittente / che singhiozza – sospirando – la sua luce” (p.27).
Ma ovviamente l’esperienza poetica di Valeria Di Felice non si esaurisce nella denuncia di queste oggettive intermittenze della quotidianità, del dinamismo della realtà delle cose, ma nel fascino di un dettato poetico che si sostanzia delle interferenze tra concretezza ed immaginazione, tra il qui e l’altrove, tra la realtà e il sogno nell’ambito di una concezione della umana vicenda, dove attesa e compimento, sosta e ripartenza costituiscono degli aspetti indispensabili affinché il corso degli eventi abbia la possibilità di realizzarsi nei modi e nei tempi dettati dall’uomo, in obbedienza, in qualche modo e in qualche misura, alla sua ontologica mobilità e disponibilità.
Insomma, è una maniera per dire che l’evidenza non è sufficiente a prendere coscienza della propria condizione di sicurezza e sussistenza. Tale presa di coscienza ha bisogno di certezze diverse tra le quali, in primo piano, il sentimento sociale, la fiducia in se stessi e negli altri, nei termini di una concezione dell’esistenza in cui ognuno non è solamente una identità molecolare certificata dalla realtà delle cose, ma una identità integrata con obblighi precisi verso se stessi, ma soprattutto verso i propri simili, coinvolti in una medesima condizione esperienziale e morale.
Ciò è la dimostrazione di una strumentalità creativa ed espressiva personalissima, soprattutto sul piano stilistico. Non uno stilismo legato ad una specifica ricerca linguistica, ma ad una sorta di metaforismo immaginistico che non ha finalità pedagogiche, ma figurative, nei termini di un descrittivismo che è lo specchio della sua interiorità tesa a cogliere gli aspetti più reconditi e significativi dell’esistenza umana, le cause prime del divenire delle cose unitamente alla virtualità epifanica dei propri sentimenti. In altri termini, sono pensieri ed osservazioni che s’intrecciano in una vertiginosa cascata di immagini, intuizioni, affermazioni, nell’ambito di una configurazione in cui segno verbale ed impressione emotiva coincidono.
Ogni pausa di riflessione
un soffitto di pensieri
che si dimentica del cielo.
Ogni tarlo del sospetto
una calza bucata
che non contiene le gambe dell’amore.
Ogni carezza sulla guancia
un soffio nel vetro
che non trasforma la fragilità
in una vela di mare.
(La vela, pag.37)
Ci troviamo di fronte, dunque, ad una esperienza poetica che percorre i sentieri del tempo interiore, del tempo vissuto, il cui piede non calca più una realtà stabile e, di conseguenza, fuoriesce dal tempo della realtà per vagare in spazi e atmosfere create dall’immaginazione, unica facoltà dell’uomo atta a fornire strumenti in grado di riscattare, con la parola, i disagi della vita, le deficienze e le resistenze di un mondo limitato. Una poesia cioè che stilla dolcezze e fantasie, una logica fascinosa dell’irreale sugli eventi e le amarezze della vita.
Ciò può dare, d’acchito, l’impressione che vi sia, nella ricerca poetica della Di Felice, un atteggiamento d’estraneità, una nota d’indifferenza precostituita, ma, a ben guardare, è soltanto una forma dubitativa, un pretesto che scaturisce da un sentimento di saggia prudenza, di meditato giudizio sulla realtà delle cose. Ella osserva la realtà, valuta, tira le somme ed agisce. Ciò le consente di coagulare le proprie emozioni e fare una registrazione della realtà che le consenta di liberare le proprie facoltà creative al massimo livello della sua sensibilità psicologica e delle sue potenzialità conoscitive e creative.
Pietro Civitareale