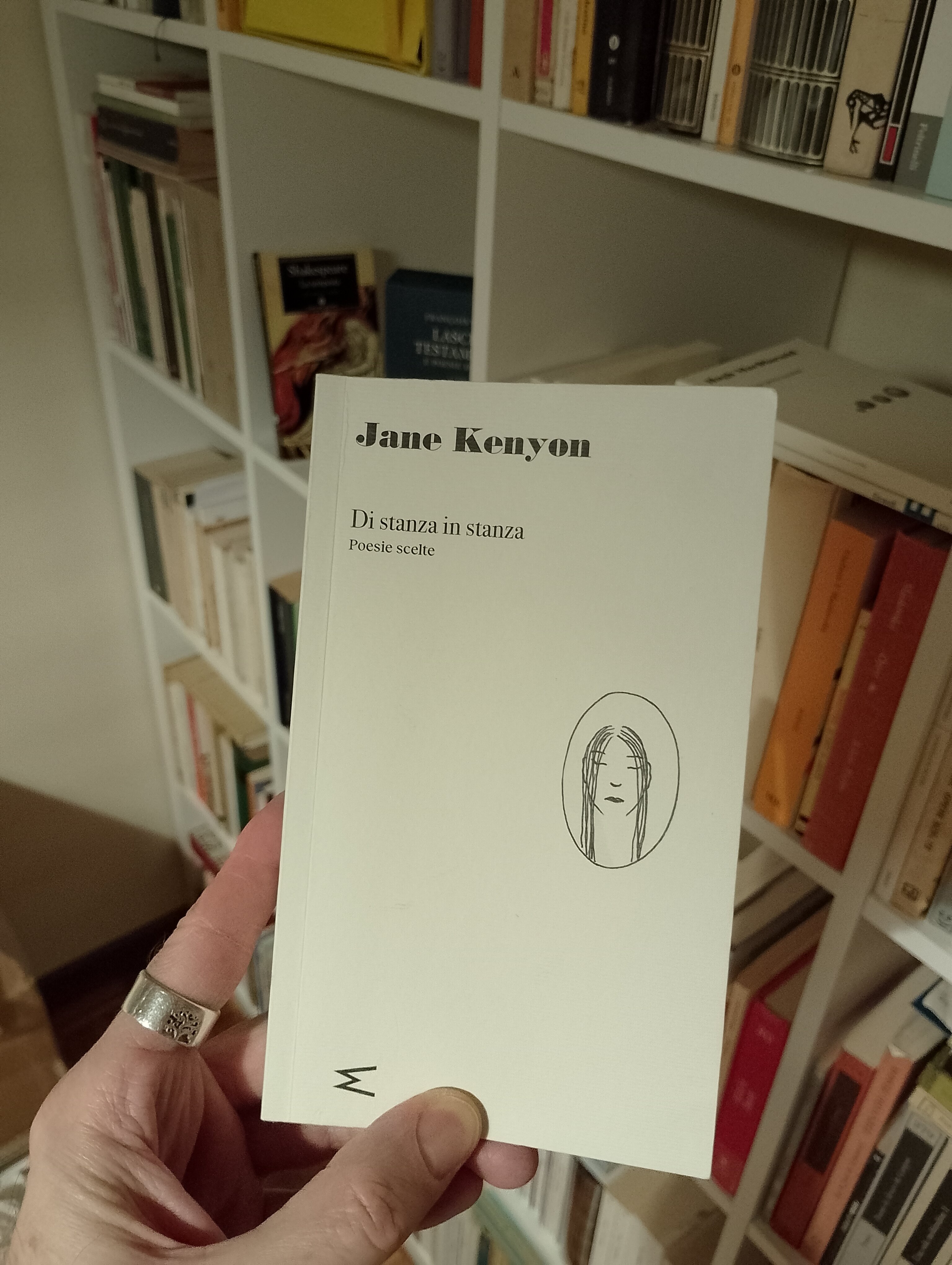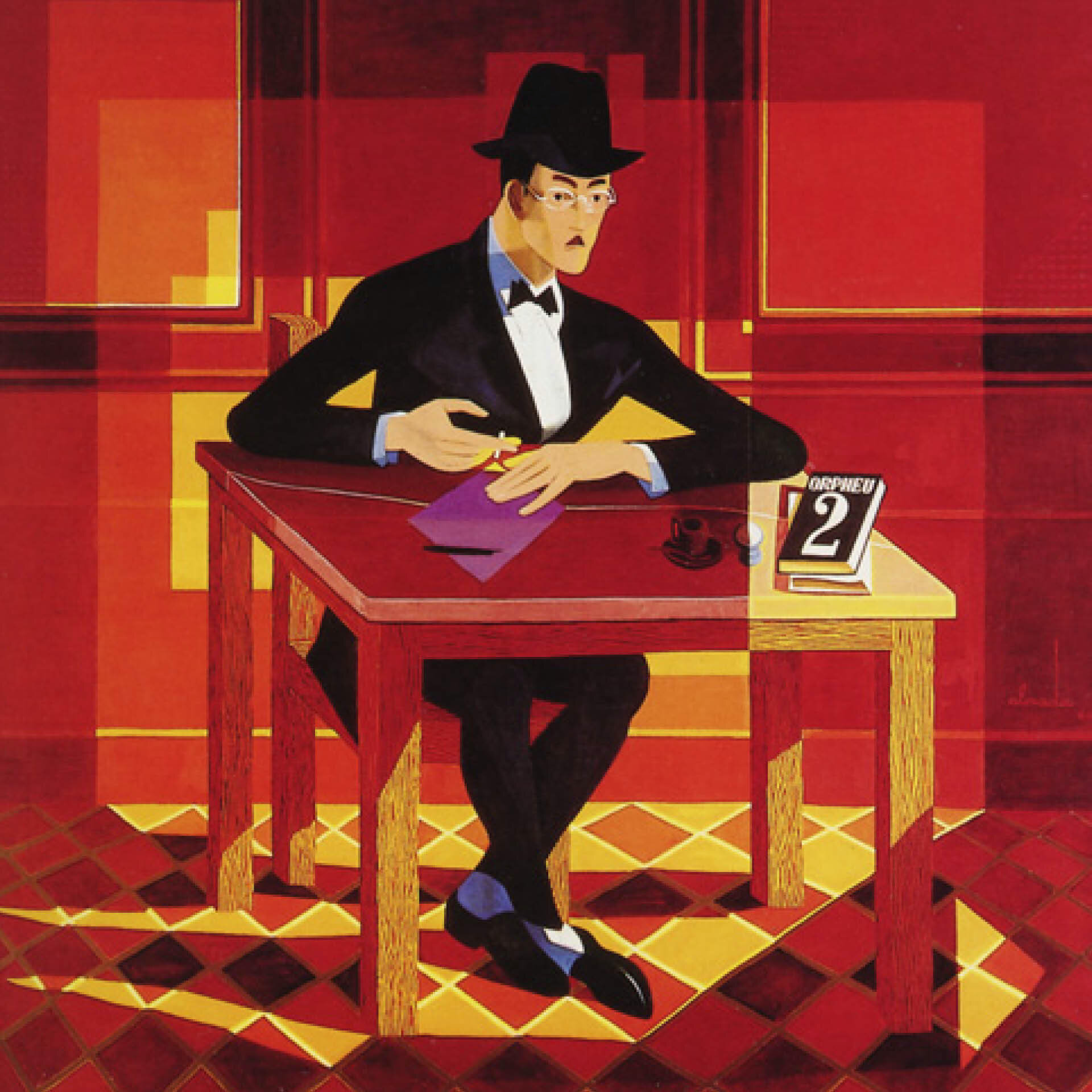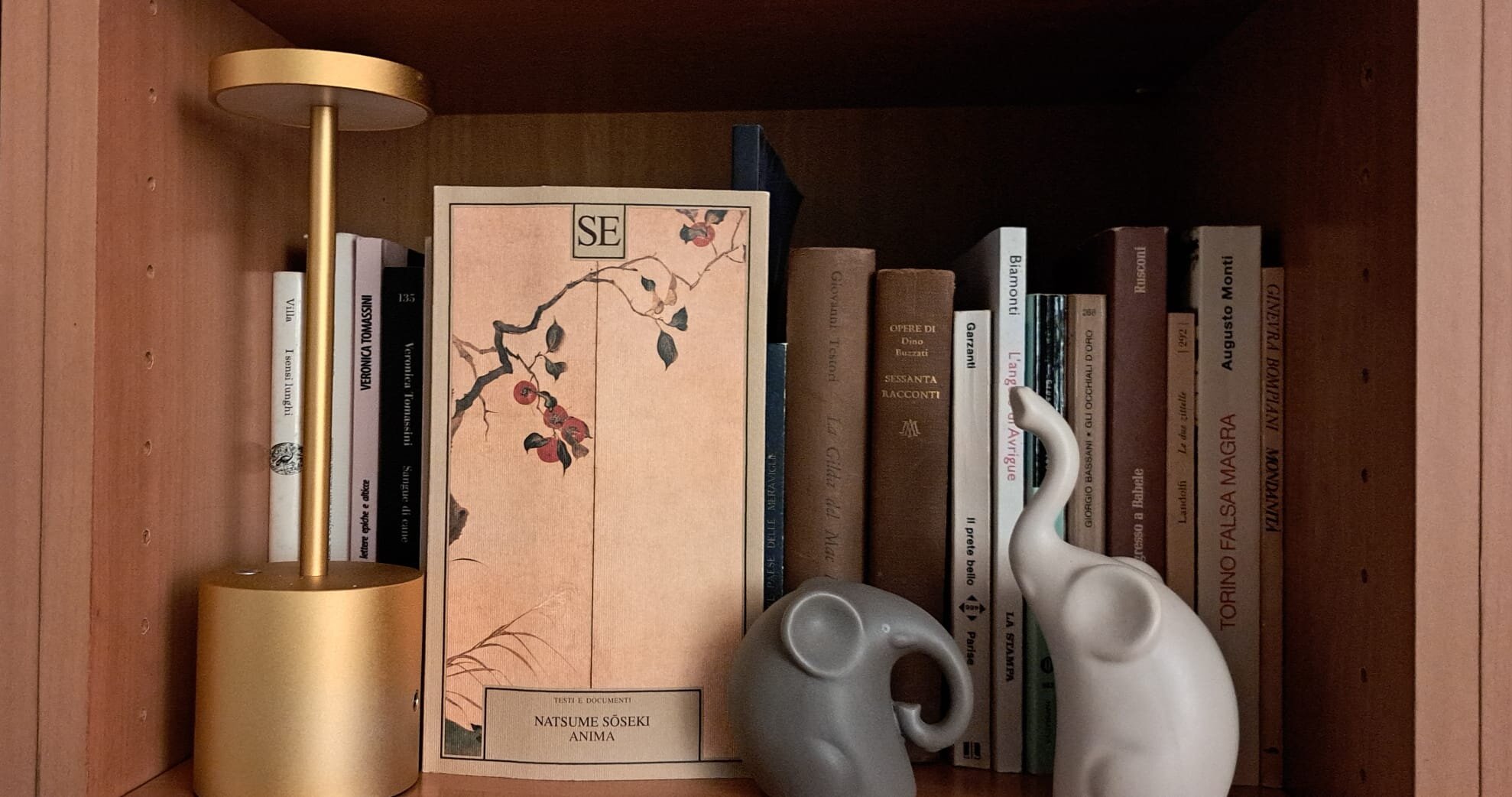I fear a Man of frugal Speech
I fear a Man of frugal Speech -
I fear a Silent Man -
Haranguer - I can overtake -
Or Babbler - entertain -
But He who weigheth - While the Rest -
Expend their furthest pound -
Of this Man - I am wary -
I fear that He is Grand
F663 (1863) / J543 (1862)
Temo un uomo che parla poco
temo un uomo silenzioso-
l'arrigantore - posso sovrastarlo
o il chiacchierone - intrattenerlo-
ma colui che pondera - mentre gli altri-
spendono fino all'ultima moneta-
di questo uomo - io diffido-
temo che egli sia grande.
Il potere del silenzio
La poesia I Fear A Man Of Frugal Speech di Emily Dickinson, sebbene molto breve, offre una riflessione intensa e penetrante sulla forza che può risiedere nel silenzio. Con uno stile misurato e un tono di rispettosa cautela, la voce narrante confessa di temere chi parla poco: non perché lo consideri strano o distante, ma perché riconosce in lui un potenziale profondo, forse anche minaccioso. Al contrario, si sente perfettamente in grado di gestire le persone loquaci, coloro che parlano molto e senza filtro. Questo contrasto rivela una verità sottile ma potente: non è chi si esprime a voce alta ad avere necessariamente più forza, ma chi sa trattenere e pesare le parole.
Parlare poco non significa avere poco da dire
Dickinson ci presenta l’“uomo di parola frugale” come una figura tutt’altro che debole o insignificante. Anzi, il suo silenzio lo rende persino più autorevole e, per la narratrice, più inquietante. Mentre gli altri "spendono" le loro parole, lui le misura. Questa scelta di rimanere in silenzio o parlare con parsimonia viene associata a una forma di controllo, di dominio interiore: chi pesa le parole con attenzione potrebbe avere pensieri più profondi, riflessioni più ponderate, o una capacità di giudizio più lucida. È proprio questa consapevolezza che genera nella narratrice non solo rispetto, ma anche un senso di timore.
Le parole come moneta: immagini di valore
Un aspetto interessante della poesia è l’uso di metafore economiche: le parole vengono rappresentate come un bene da spendere, e quindi dotate di valore. I chiacchieroni “spendono fino all’ultimo penny” del loro pensiero, mentre l’uomo silenzioso sembra conservare qualcosa di più prezioso. È come se Dickinson ci invitasse a riflettere sul significato e sul peso di ogni parola: parlare troppo, senza attenzione, può portare a un impoverimento del pensiero; parlare poco, al contrario, può indicare una mente vigile, selettiva, potente.
Una grandezza che fa paura
Alla fine della poesia, la narratrice dice chiaramente: “Di quest’uomo io diffido – temo che egli sia grandioso”. L’aggettivo “grand” (grandioso) è carico di significato: non si riferisce a una grandezza visibile, appariscente, ma a qualcosa di più profondo, forse nascosto. Potrebbe trattarsi della grandezza del pensatore silenzioso, del saggio, ma anche di quella di una figura inaccessibile, distante, potenzialmente pericolosa. Questa ambivalenza arricchisce la poesia, perché ci costringe a chiederci: cosa rende davvero una persona “grande”? Il silenzio è una maschera, una difesa, o una forma di saggezza?
Conclusione: il rispetto per l’invisibile
Attraverso questa poesia, Dickinson ci offre una riflessione originale e ancora oggi attuale sul potere del silenzio. La voce narrante non teme chi parla molto, ma chi sa restare in silenzio, chi non rivela tutto di sé. C’è qualcosa di misterioso, e forse di pericoloso, in chi non si svela completamente. Ed è proprio questo che affascina: la possibilità che dietro il silenzio si nasconda una grandezza silenziosa ma reale. La poesia ci invita a non sottovalutare ciò che non vediamo o non sentiamo: a volte, le parole non dette pesano più di quelle pronunciate.
Traduzione e commento di Valentina Meloni