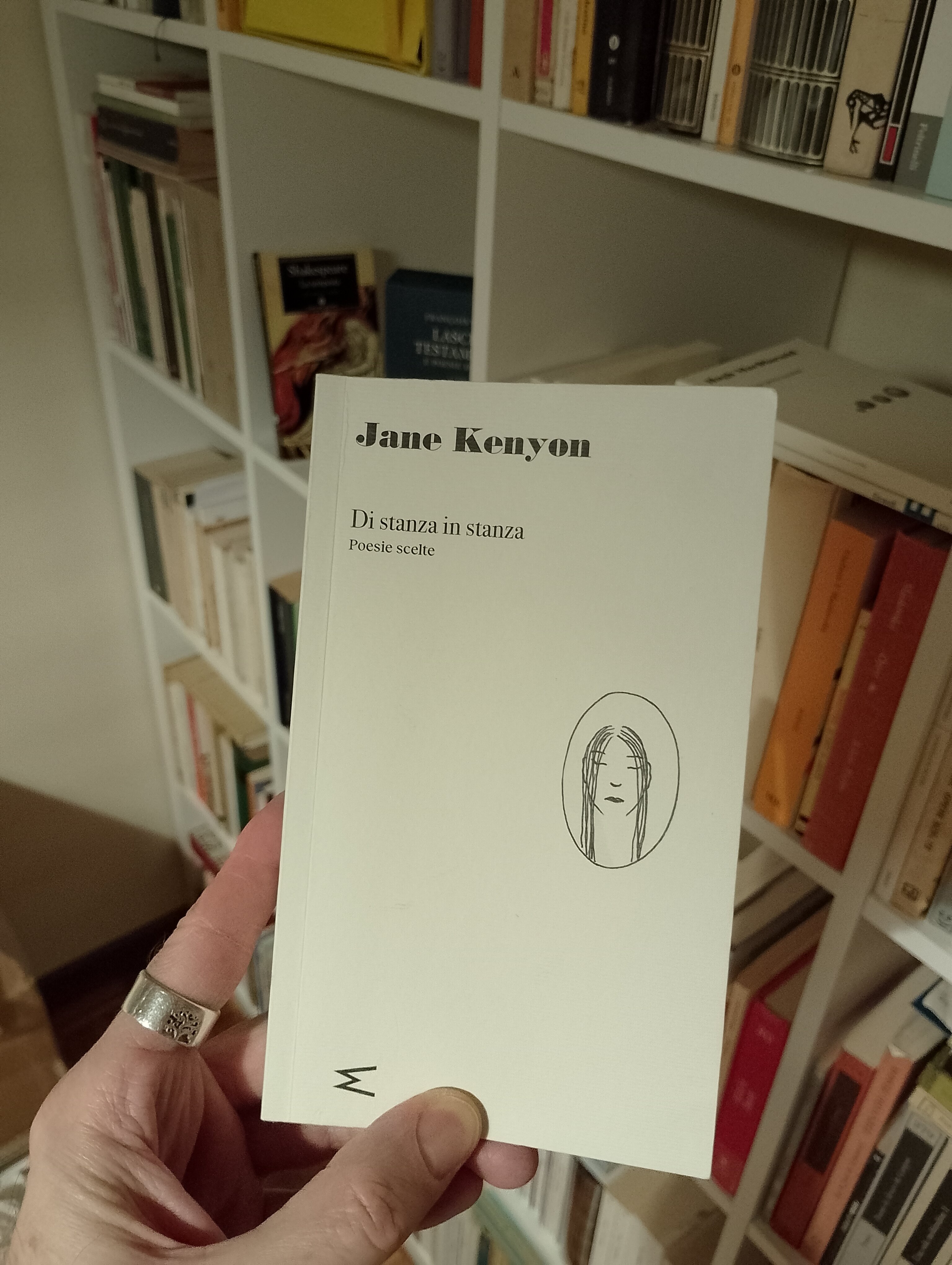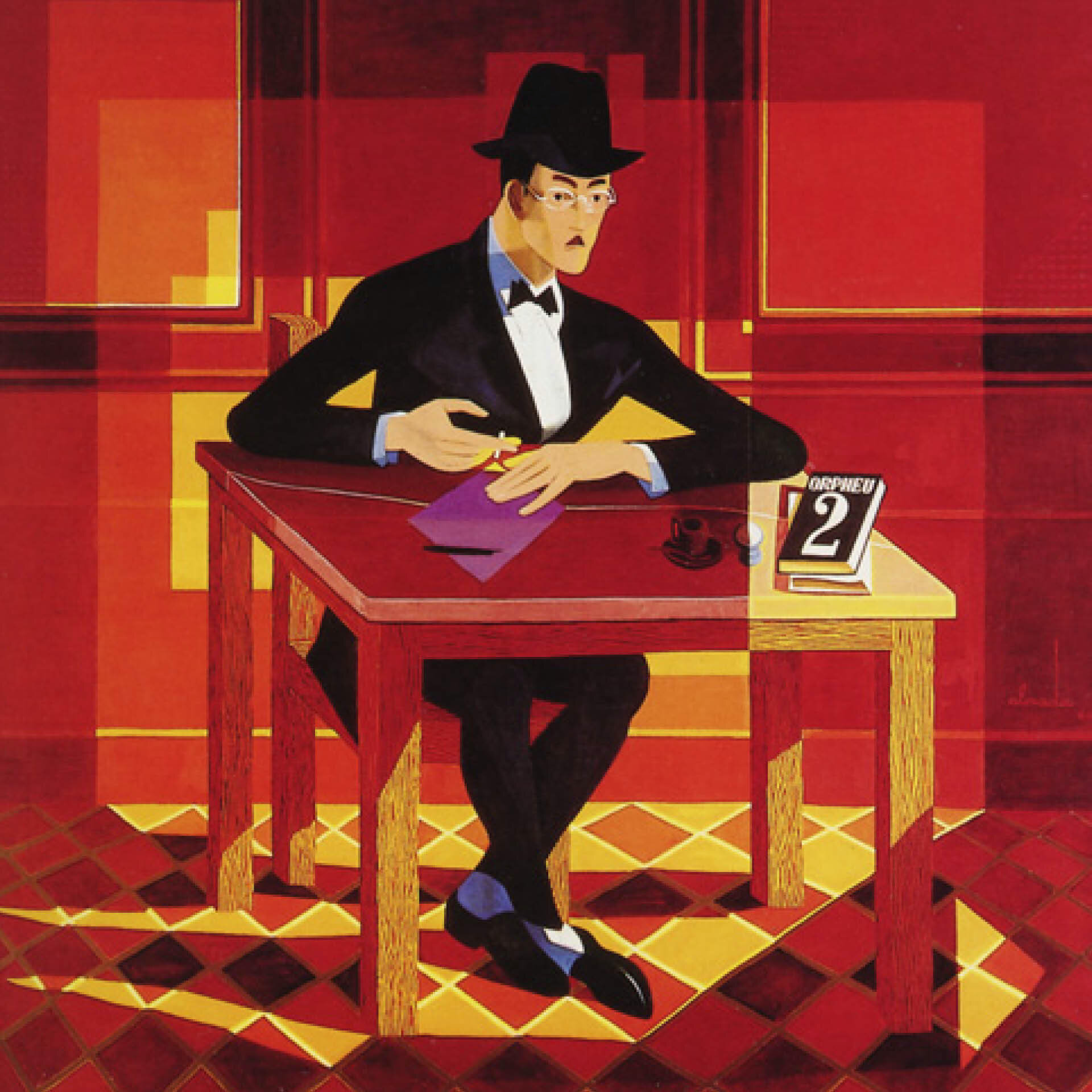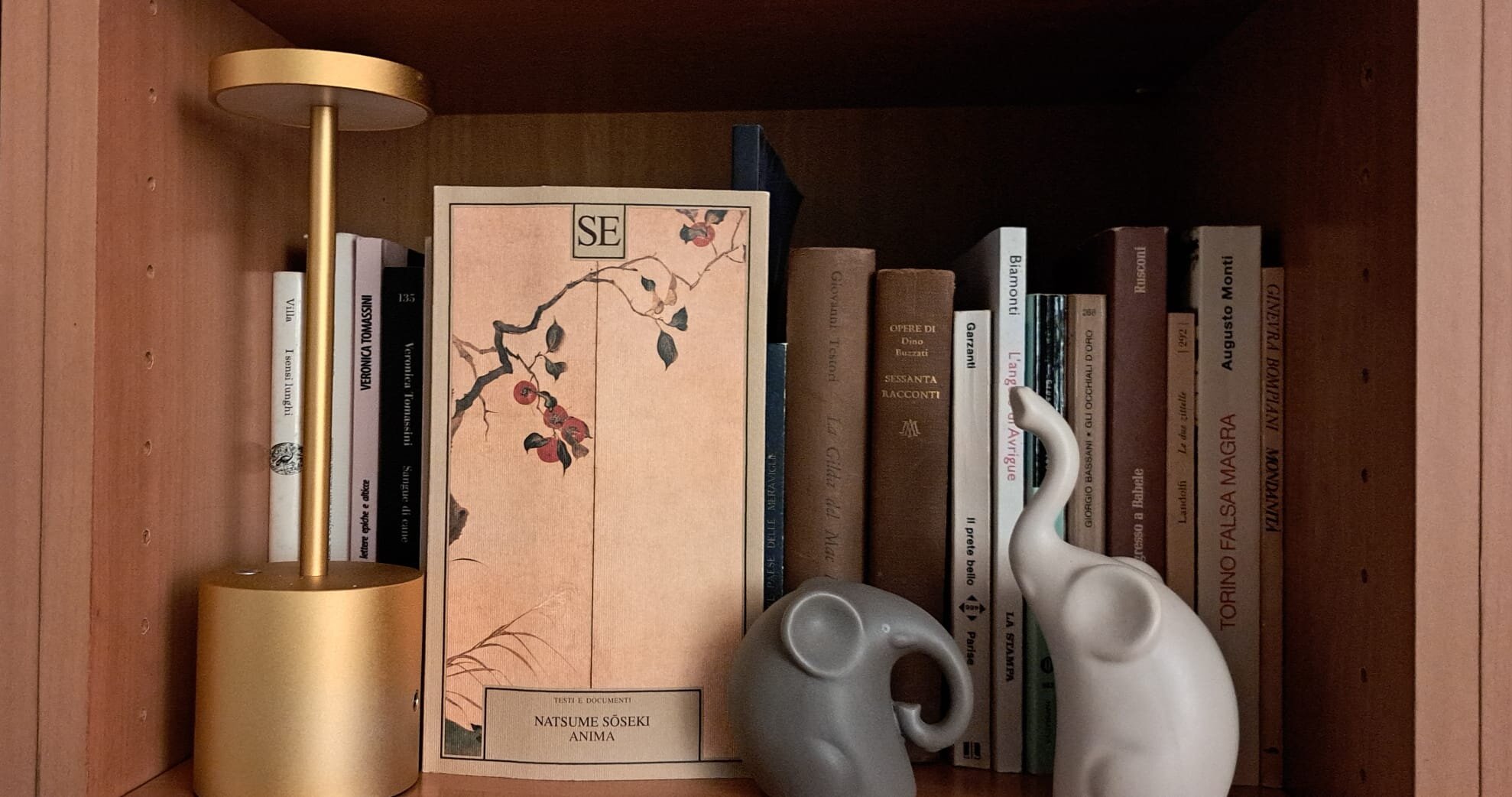Uomini che avete orrore del fuoco,
poveri esseri di paglia!
(A. Palazzeschi, L’incendiario)
Così un giovane Palazzeschi rimproverava uomini e donne riuniti per linciare colui che appicca il fuoco, nel suo poemetto L’incendiario (1910). Il poeta, giunge per cantare quest’uomo rinchiuso nella gabbia, lo apostrofa come santo, lanciandosi in una sfrenata ode del disastro:
Santo quando pensi di bruciare,
Santo quando abbruci,
Santo quando le guardi
le tue fiamme sante!
(A. Palazzeschi, L’incendiario)
Palazzeschi è nel suo primo innamoramento futurista e non può che farsi portavoce, come altri poeti, di questa gioia per la distruzione, questa inesprimibile (se non con la poesia) voglia di sfasciare ogni cosa. Il poemetto, lasciato un po’ in disparte durante la maturità e difatti non inserito nella tarda ripubblicazione delle opere giovanili, è fra le prime testimonianze di quell’aria di rinnovamento oramai inarrestabile che spira ovunque, un’aria che scuote in particolare paesi come l’Italia, ancora addobbata con vesti ottocentesche.
Questa passione per l’annichilimento è comune a moltissimi poeti in tutto il mondo, anzi, potremmo dire sia una scossa che attraversa tutto il mondo delle lettere. La primavera annunciata da William Carlos Williams in La primavera e tutto il resto (1923) è una stagione violentissima:
Nessuno resterà; nessuno tranne i più infimi vertebrati, i molluschi, gli insetti, le piante. Allora infine il mondo sarà rifatto nuovo.
[…] Questo terminale auto-inflitto olocausto è stato solo per amore, per l’amore più dolce.
(W. C. Williams, La primavera e tutto il resto)
E la Russia rivoluzionaria non è stata da meno, si legge infatti nella poesia A Sergej Esenin di Majakovskij:
Per prima cosa
bisogna
rifare la vita,
una volta rifatta,
si potrà esaltarla.
(V. Majakovskij, A Sergej Esenin)
Non si può dire che questi poeti, a cavallo dei primi decenni del Novecento, non siano stati esauditi. Ma il loro numero è maggiore, moltissimi sono infatti gli scrittori che hanno profetizzato, o meglio, interpretato i tempi catastrofici che avrebbero trovato il loro culmine nella bomba atomica. Viene spesso da domandarsi se questi autori abbiano contribuito all’esplosione, se abbiano attizzato il fuoco, o se abbiano soltanto dato voce a un sentimento che doveva essere espresso, un sentimento inevitabile e latente che trova espressione nella poesia, come risultato della stagnazione che pervadeva l’arte come la poesia. L’impressione generale è che l’uomo arrivi al XXI secolo come a un punto di non ritorno: morire e rinascere, rinnovarsi, o scomparire.
A ogni intento di distruzione segue sempre un intento di ricostruzione, distruggere per ricostruire, quasi che le pezze, le correzioni in calce, non siano più sufficienti, ma occorra invece spazzar via ogni cosa perché la terra si sgombra per la nuova magnifica costruzione. Eppure ciò non sembra sia accaduto. Parrebbe che l’uomo sia molto più portato a distruggere che a costruire, che l’accelerazione non abbia portato al raggiungimento della terra promessa, ma soltanto a un aumento della velocità. Un’accelerazione fine a se stessa.
Tornando a Majakovskij, non si può ignorare una peculiarità facente parte della sua produzione giovanile. Nel 1915 ultimò il suo poema La nuvola in calzoni, presentato come un “tetrattico”, cioè suddiviso in quattro parti, un termine che riporta la mente (se non la nostra, di certo l’uomo russo del suo tempo) all’iconografia ortodossa. Inoltre, il poema doveva originariamente intitolarsi “Il tredicesimo apostolo”, titolo bocciato dalla censura zarista. Questi sono solo i più evidenti riferimenti religiosi, in aperto e voluto contrasto con il suo contenuto, un attacco serrato proprio nei confronti di tutto, dall’amore alla società, dalla religione alla poesia.
Oggi
col pugno di ferro
bisogna
al mondo il cranio spaccare!
(V. Majakovskij, La nuvola in calzoni)
“Tredicesimo apostolo” è anche l’appellativo che viene dato a San Paolo. Non sembra un caso, dal momento che un passaggio fondamentale del messaggio di San Paolo è proprio questa nuova vita che attende i cristiani, questa rinascita in Cristo. Leggiamo nella Lettera agli Efesini:
Ora dunque vi dico e vi scongiuro nel Signore: non comportatevi più come si comportano i gentili con i loro folli pensieri, ottenebrati come sono nell’intelletto, estranei alla vita di Dio, a causa della loro ignoranza e dell’indurimento del cuore. Divenuti insensibili, si sono abbandonati agli stravizi, fino a commettere con insaziabile frenesia ogni genere d’immondizia. Voi però non avete imparato così il Cristo, se realmente lo avete ascoltato e in lui siete stati istruiti com’è verità in Gesù. Spogliatevi dell’uomo vecchio, quello del precedente comportamento che si corrompe inseguendo seducenti brame, rinnovatevi nello spirito della vostra mente e rivestitevi dell’uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella santità della verità. (Ef, 4, 17-24)
Già nella Lettera ai Romani San Paolo parla di “creatura nuova”; come specifica Gianfranco Ravasi nella sua biografia di San Paolo, “l’uomo non è solo guarito dalle sue ferite ma del tutto rinnovato, ‘ri-creato’, diventa intimo e figlio di Dio. Come Cristo è entrato morto nel sepolcro di pietra e ne è uscito vivente e glorioso, così l’uomo che entra nel sepolcro d’acqua del battesimo lascia le spoglie della sua corruzione e ne esce risorto e creatura nuova” (G. Ravasi, Ero un blasfemo, un persecutore e un violento, Raffello Cortina Editore, 2024, p.83). Forse si incomincia a intravedere un nesso fra quell’onda di rinnovamento novecentesca e il più antico e rivoluzionario messaggio di Cristo nelle parole di San Paolo:
Stolto, ciò che tu semini non prende vita se prima non muore (1Cor, 15, 36)
Quel morire per rinascere nelle parole dei poeti appare come l’eco del Vangelo, con una differenza sostanziale: San Paolo esorta a rinascere in Cristo, mentre quella voglia di distruzione di inizio ‘900 sembra fine a se stessa. Certo non manca l’amore nelle parole di Palazzeschi, di Williams e di Majakovskij, ma non è un amore come quello del messaggio di Cristo. Non ne ha la potenza. Quella morte, quel mettere da parte l’uomo vecchio, è stata presa alla lettera, con ogni tragica conseguenza. Ma non sarà che quell’uomo nuovo che i poeti andavano cercando fosse in realtà proprio l’uomo nuovo di San Paolo, l’uomo rinato in Cristo, e che cercando altrove abbiano trovato soltanto distruzione?
Potremmo dire allora che quel punto di non ritorno in cui inciamparono poeti, filosofi e scrittori alle soglie del Novecento sia ancora lì, sospeso sulla testa dell’uomo moderno. Incapaci di trovare la formula per quell’uomo nuovo, mentre stava da secoli sotto il loro naso.
Valerio Ragazzini