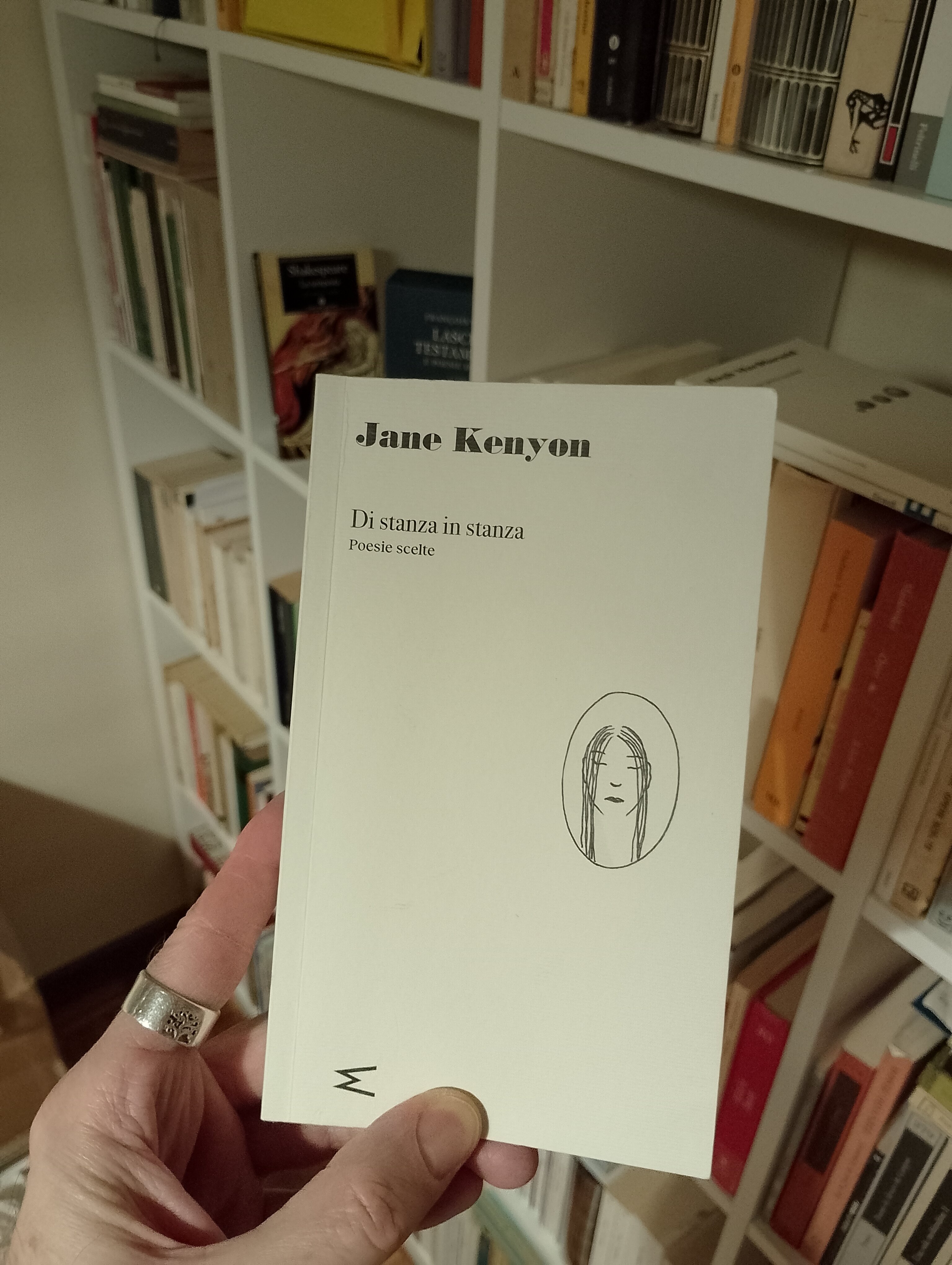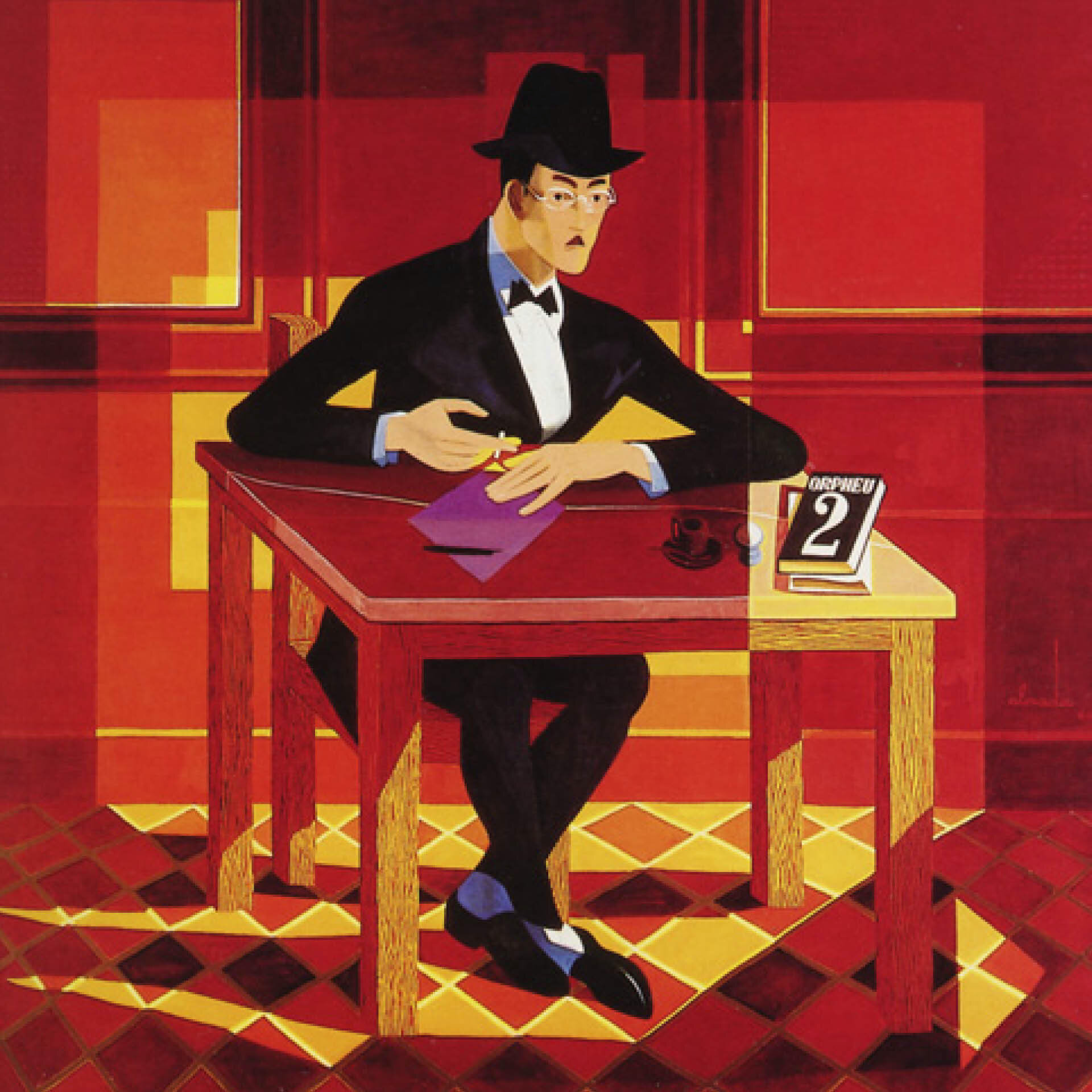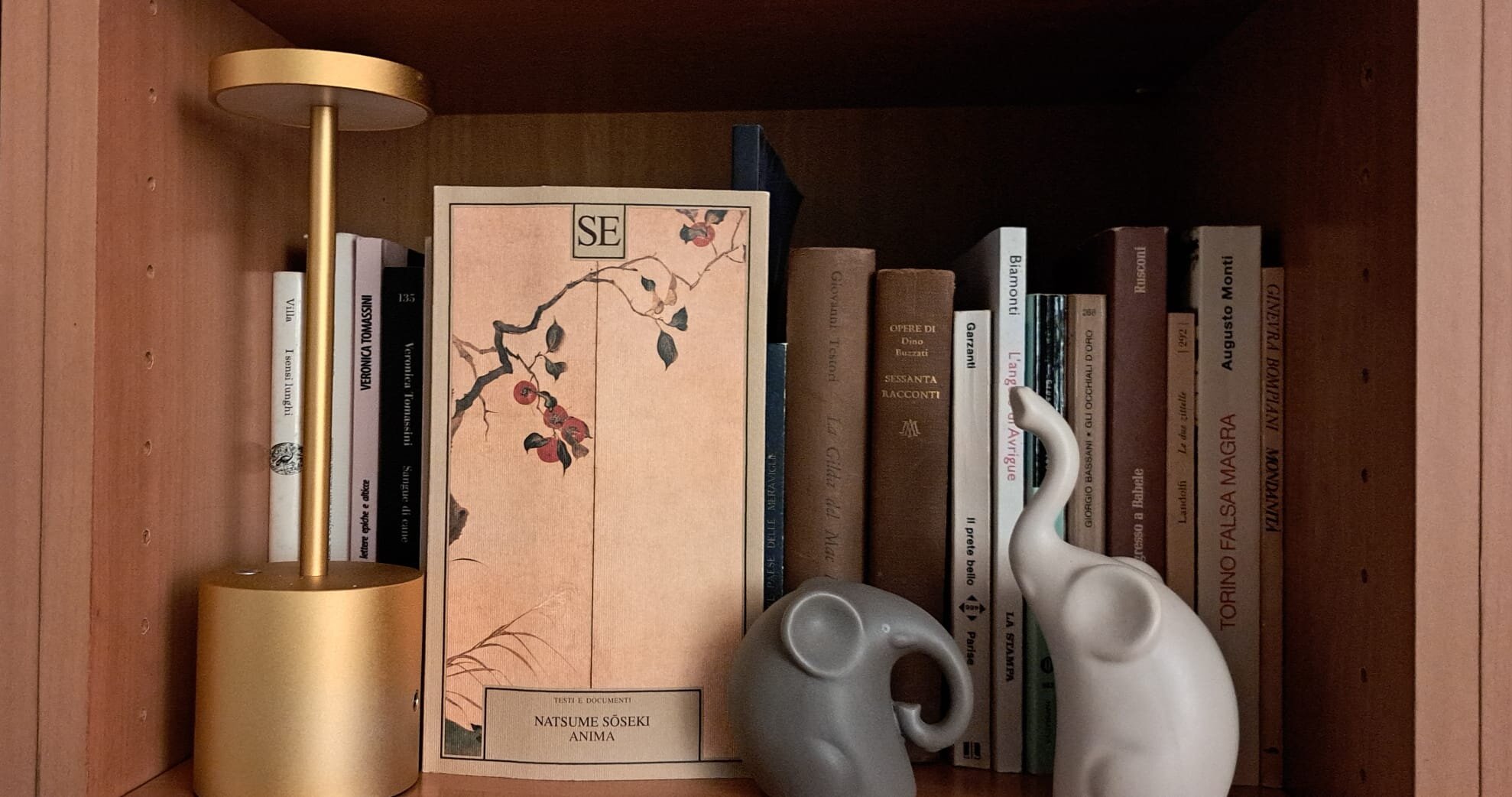C’è un confine oltre il quale il dolore perde la sua riconoscibilità umana e diventa preda della spettacolarizzazione, un confine oltre il quale il proprio vissuto – soprattutto quello sofferto, usurpato – si ripiega su se stesso e sprofonda in quel pozzo nel quale non riesce ad arrivare nemmeno l’eco dei lettori.
Poi c’è un altro confine – quello della poesia autentica – oltre il quale il dolore apre un varco verso l’ignoto, verso uno spazio di attraversamento che ingloba la dimensione dell’appartenenza a un unico orizzonte, quello dell’umanità senza divisioni di sorta. Perché è nelle geografie del paradosso, quelle che si disegnano nei mappamondi interiori, che il confine e il non-confine si fondono in uno specchio che vive di luce e riflesso propri, vive dell’essere nel mondo misteriosamente e a prescindere da noi stessi. Ed è proprio in questa pangea circondata dallo stesso mare, che la parola di Widad Nabi, poetessa curdo-siriana nata a Kobane e cresciuta ad Aleppo e dal 2015 rifugiata a Berlino, sa cogliere l’essenza di un percorso travagliato ma anche espanso in tutte le sue manifestazioni emotive. Una voce poetica, la sua, dotata di carisma e nudità di ispirazione, senza orpelli retorici o perifrasi inautentiche. Una poesia che diventa l’emblema di un corpo, di un continente che unisce la peculiarità delle radici alla comunanza dello sguardo umano.
Widad Nabi che ha dovuto lasciare la Siria per il suo impegno culturale e letterario contro il regime di Bashar al-Assad, ha affrontato con coraggio la strada dello sradicamento per poi trovarne un’altra, rendendo le sue radici ancorate alla condizione umana.
Un continente chiamato corpo, raccolta tradotta con cura da Simone Sibilio, innesta temi politici, sociali, bellici, intimistici in un unicum, in un planisfero che diventa la rappresentazione stessa dell’essere nel mondo.
L’esilio e la drammaticità della guerra, con tutta l’incombenza della morte, percorre la maggior parte delle poesie: «So bene che ogni cosa è destinata a morire. / Da bambina / ho visto mia madre riporre il suo fazzoletto colorato / sulla tomba di un nostro parente. / Appresi che nulla resta di ciò che amiamo a parte i fazzoletti. / Loro sanno bene dire addio / con un piccolo cenno della mano / come una lacrima salata.»
Il linguaggio si sofferma sul corpo delle ferite, sulle cicatrici della memoria, sui passi in movimento alla ricerca di un approdo. Tuttavia, la parola di Widad Nabi non è solo speranza agognata di un rifugio, ma è qualcosa di più: è casa viva, è antidoto all’alienazione dalla terra divelta del suo cuore, è rete interiore che continua a trattenere un mare di vita nonostante tutto: «In principio, / la eleggono a casa / gli concedi le chiavi, i segreti, le fonti del piacere / ma loro prontamente la bombardano / e se ne vanno. // Il tuo corpo rifiorisce / ad ogni battaglia / una pianta bombardata dal vento, lontano. / Ogni poro si libera dei respiri dei passanti, i loro / sguardi, i sospiri / adesso il tuo corpo è un continente intero, / con i suoi mari ed oceani, i monti e le valli / e nessuno potrà gridare: / questo continente è mio.»
L’apice di questo irresolubile destino collettivo che sembra accanirsi ostinatamente sul popolo siriano di quegli anni fagocitando in un’unica morsa i giorni dei singoli, lo troviamo nelle liriche dedicate alla maternità: madri in carne e ossa che muoiono o che sopravvivono ai figli, madri che diventano quella corda tesa tra cielo e terra a simboleggiare il richiamo ancestrale a un mistero che sembra indifferente all’atrocità della guerra.
«In guerra / una madre che perde un figlio / non invecchia / le rughe non le riempiono il viso / i suoi capelli non sbiancano. / Una madre teme che suo figlio dopo la morte non la riconosca più. //… Il cuore di una madre / perdona ogni dolore. / Per questo la guerra non ha mai smesso di venirci a trovare.»
In questa curvatura coscienziale troviamo da un lato lo scontro con le nefandezze e le storture del mondo, il suo volto disumano; dall’altro la ricerca di una riva altra, di una sponda che possa ridare metaforicamente – e non solo – dignità.
Sarebbe riduttivo, però, considerare queste liriche solo il frutto dell’esilio e degli sconvolgimenti bellici e civili della Siria degli ultimi decenni: troviamo anche la tensione generazionale tra emancipazione e una tradizione già di per sé complessa perché permeata da componenti curde, arabe siriane, islamiche e laiche; la vigorosità della carne del mondo che cerca di disfarsi delle zavorre di un modello patriarcale troppo idealizzato sull’imperativo del ruolo sociale o familiare, e che cerca invece di accordarsi a un canto capace di esaltare i desideri profondi di ciascuno.
Senza alcuna deriva intimistica, la poesia di Widad Nabi è un affondo anche nell’universo femminile, in cui si sente ancora di più il contrasto generazionale e in cui si coglie l’essenza dell’introspezione esistenzialista e della relazione affettiva. Molte poesie sono affondi nell’immaginario erotico di un io lirico declinato al femminile che, attraverso il suo sguardo inedito sul mondo del piacere e del desiderio, non ha reticenze nel condividere poeticamente l’esperienza dell’amore, anche quello carnale. La parola diventa in questo caso anche atto impegnato che ribadisce il diritto delle donne di manifestare artisticamente il proprio mondo erotico. Svelare la propria sensualità, ridare luce al corpo, ai suoi respiri, alla sua voluttà, significa anche togliere quel cono d’ombra che per secoli ha imprigionato l’integrità delle donne nell’esclusiva funzione riproduttiva di madre e di moglie.
«La notte, la voglia di noi / rotola sul letto come mezza luna / mentre la tua bocca, come pesce viscoso, / leggera mi scivola nell’acqua. / Poco più distanti le mie natiche / smaniose di ghermire la tua potente fragranza di muschio.»
Per concludere, potremmo riassumere che la poesia di Widad Nabi sembra sgorgare da una stremata inquietudine e da una estenuata sensibilità. Una poesia che apre la porta verso un’abitabilità pacifica tra sistemi socioculturali diversi; una poesia che parla al cuore di tutti, uomini e donne; una poesia che si fa interprete dell’incontro e della risorsa più preziosa che abbiamo: la relazione.
Un continente chiamato corpo, di Widad Nabi (Di Felice Edizioni, 2025, traduzione e prefazione di Simone Sibilio, postfazione di Ilaria Giovinazzo). Opera vincitrice del Premio Internazionale Camaiore-Belluomini e del Premio Speciale Oreste Pelagatti-Civitella del Tronto.
Valeria Di Felice