Torino, 15 maggio 1935 La città si sveglia bruscamente: un’importante operazione di polizia politica è in corso, vengono perquisite le abitazioni di molti giovani intellettuali sospettati di essere attivisti o simpatizzanti antifascisti: da tempo venivano osservate le loro frequentazioni, abitudini, amicizie, relazioni e movimenti. Gran dispendio di polizia quel mattino, si deve agire presto e in fretta per cogliere i giovani di sorpresa, la tazzina di caffè in mano, il letto ancora caldo; si deve evitare che possano distruggere materiale compromettente, far girare la voce dell’operazione in corso. Molti di loro verranno arrestati ed interrogati presso le Carceri Nuove di Torino: tra i tanti Norberto Bobbio, Massimo Mila, Giulio Einaudi, Leone Ginzburg, Franco Antonicelli, Carlo Levi, Cesare Pavese. Pavese a quel tempo è il direttore responsabile di “La Cultura”, rivista pubblicata dalla neonata casa editrice Einaudi ed invisa al regime fascista per le autorevoli firme di intellettuali antifascisti che ospita. Tra le sue carte, durante la perquisizione, viene trovato un copioso fascio di lettere tra Tina Pizzardo e Bruno Maffi, entrambi legati al movimento antifascista clandestino “Giustizia e Libertà”: tutto ciò è più che sufficiente per arrestare Pavese, ventisettenne, e sottoporlo a interrogatorio. Vanamente egli spiegherà di non avere mai svolto attività antifascista – egli stesso è iscritto al Partito Nazionale Fascista, a breve deve dare l’esame di stato per conseguire l’abilitazione all’insegnamento ‒ e di avere soltanto dato il suo consenso a far recapitare quelle lettere al suo domicilio per fare un favore alla Pizzardo, grande, folle e disperato amore di Pavese, la “donna dalla voce rauca”: fidanzata ufficiale di Altiero Spinelli (detenuto all’epoca a Regina Coeli). Tina frequentava, all’insaputa l’uno dell’altro, sia Pavese che Enrico Rieser, un giovane di origini polacche. Travisando i sentimenti di lei, poco prima di essere arrestato Pavese la chiese in moglie e nutriva serie speranze – come si deduce dalle lettere che scriverà alla sorella Maria dal carcere romano prima, e dal confino a Brancaleone poi – di ottenere una risposta alternativa. Nel corso dell’interrogatorio viene chiesto a Pavese di dare conto di alcuni appunti e di un elenco di nomi scritti di suo pugno trovati tra le sue carte: spiegherà trattarsi dell’abbozzo del progetto, non andato in porto, di un gruppo di amici, poco più che ventenni, di fondare una rivista letteraria dal titolo eloquente negli anni del fascismo: “VOCI LIBERE “, come le menti ed i desideri dei giovani intellettuali che vi avrebbero scritto. Pavese non convince gli inquirenti: viene trasferito a Roma a Regina Coeli, processato e condannato a scontare tre anni di confino, a Brancaleone Calabro. *-* E’ il 9 di agosto quando da Brancaleone scrive alla sorella così: “Cara Maria, sono arrivato a Brancaleone domenica 4 nel pomeriggio, e tutta la cittadinanza a spasso davanti alla stazione pareva aspettare il criminale che, munito di manette, tra due carabinieri scendeva con passo fermo, diretto al Municipio. Il viaggio di due giorni, con le manette e la valigia, è stata un’impresa di alto turismo. (…) Qui sono l’unico confinato. Che qui siano sporchi è una leggenda. Sono cotti dal sole. Le donne si pettinano in strada, ma viceversa tutti fanno il bagno. Ci sono molti maiali e le anfore le portano in bilico sulla testa. Imparerò anche io e un giorno mi guadagnerò la vita nei varietà di Torino. La grappa non sanno cosa sia. Se me ne mandate qualche ventina di bottiglie, io penserei a berle. (DICO SUL SERIO)” Il confino è un’esperienza, per un certo verso, che potrebbe non preoccupare troppo Pavese: la solitudine è sua compagna da sempre, l’isolamento una condizione non disprezzata, spesse volte ricercata. Un unico tarlo lo rode: l’impossibilità di comunicare con l’amata Tina. Si fa forza, con quel piglio cinico ed ironico che contraddistingue la sua immagine pubblica, ma non può fare a meno di vivere momenti di grande sconforto: il clima umido gli procura l’asma, mangia poco e male, e pur amando nuotare (si fa spedire subito dalla sorella costume e cuffia da nuoto), il mare non è per lui. Scrive, sempre alla sorella :“Indifferente mi lasciano invece i piroscafi all’orizzonte e la luna sul mare, che con tutti i suoi chiarori mi fa pensare solo al pesce fritto. Inutile, il mare è una gran vaccata”; e ancora al suo ex professore del liceo, Augusto Monti: “Lei sa come io odi il mare; mi piace nuotare, però mi serviva molto meglio il Po. Ma a parte il nuotare, che del resto è già finito, trovo indegno della gravità di uno spirito contemplativo quel perenne giochetto delle onde sulla riva e quel basso orizzonte odor di pesce”. Eppure Pavese, uomo solo dinanzi all’inutile mare/attendendo la sera, attendendo il mattino, proprio dal mare riceverà un’intuizione importante. Così scrive nel febbraio del ‘36 ne “Il mestiere di vivere”, uno dei diari più intensi scritti da un poeta, vera e propria cartografia della sua anima: “Passare ore a rosicchiarmi le unghie, a disperare degli uomini, a disprezzare luce e natura, a temere per paure infantili e pure atroci, è un ritorno ai miei vent’anni. Quale mondo giaccia al di là di questo mare non so, ma ogni mare ha l’altra riva, e arriverò. Mi disgusto ora della vita per poterla assaporare un’altra volta” In verità, i sette mesi del confino (un provvedimento di grazia arriverà nel marzo del 1936) sono per Pavese operosissimi: legge una mole impressionante di libri in italiano, inglese, francese e tedesco, traduce dal Greco e dal Latino, analizza la tecnica del suo poetare: “quanto a me, la composizione di una poesia avviene in un modo che – se non me lo mostrasse l’esperienza – mai avrei credutoˮ Muovendomi intorno ad un’informe situazione suggestiva, mugolo a me stesso un pensiero, incarnato in un ritmo aperto, sempre lo stesso. Le diverse parole e i diversi legamenti colorano la nuova concentrazione musicale individuandola. E il più è fatto. Non resta ora che ritornare su questi due, tre, quattro versi, quasi sempre a questo stato già definitivi e iniziali, e tormentarli, interrogarli, adattare loro svariati sviluppi finché capito su quello giusto. (…) Ho davanti un complesso ritmico, pieno di colori, di passaggi, di scatti e di distensioni – dove i vari momenti di scoperta, di passi avanti ‒ i nuclei, insomma – si scambiano, si illuminano, perennemente attivati dal sangue ritmico che scorre dappertutto. Ci fumo sopra e tento di pensare ad altro, ma sorrido, stimolato dal segreto” E ancora, Pavese in questi mesi scrive poesie e lavora incessantemente alla pubblicazione di “Lavorare Stanca”, la raccolta di poesie che uscirà per Solaria all’inizio del 1936 nel suo primo nucleo originale di 45 poesie, nonostante la censura, il controllo della corrispondenza e mille altre difficoltà. “Lo Steddazzu”, scritta proprio nell’inverno del 1935, è il fotogramma di un’insonnia in un’alba uguale a tutte le altre: amara, desolata, inutile. L'uomo solo si leva che il mare e ancor buio *-* 15 marzo del '36, destinazione Torino, finalmente la condanna al confino è stata graziata. Nell’atrio della stazione di Porta Nuova non c’è Tina ad attenderlo, ma alcuni amici e la sorella Maria. Pavese in un battito di ciglia comprende perché l’amata mai gli scrisse durante tutti quei mesi, comprende il silenzio ostinato di Maria e dei suoi amici più cari, a cui continuamente chiedeva notizie di Tina. Maria non può tacere: Tina si è ufficialmente fidanzata con Enrico Rieser, le nozze saranno a breve. Pavese perde i sensi, si accascia sulla sua valigia; un nuovo squarcio sulla sua anima da cui, fino all’ultimo, sgorgherà incessantemente il fiotto della poesia. “Ho dato poesia agli uomini”, scriverà, consapevole della sua opera come dono di sé. Poco tempo dopo si congederà dalla vita, proprio di fronte alla stazione di Porta Nuova, in una camera d’albergo. Era il 27 agosto 1950. Daniela Bianco
e le stelle vacillano. Un tepore di fiato
sale su dalla riva, dov'è il letto del mare,
e addolcisce il respiro. Quest'è l'ora in cui nulla
può accadere. Perfino la pipa tra i denti
pende spenta. Notturno è il sommesso sciacquio.
L'uomo solo ha già acceso un gran fuoco di rami
e lo guarda arrossare il terreno. Anche il mare
tra non molto sarà come il fuoco, avvampante.
Non c'è cosa più amara che l'alba di un giorno
in cui nulla accadrà. Non c'è cosa più amara
che l'inutilità. Pende stanca nel cielo
una stella verdognola, sorpresa dall'alba.
Vede il mare ancor buio e la macchia di fuoco
a cui l'uomo, per fare qualcosa, si scalda;
vede, e cade dal sonno tra le fosche montagne
dov'è un letto di neve. La lentezza dell'ora
è spietata, per chi non aspetta più nulla.
Val la pena che il sole si levi dal mare
e la lunga giornata cominci? Domani
tornerà l'alba tiepida con la diafana luce
e sarà come ieri e mai nulla accadrà.
L'uomo solo vorrebbe soltanto dormire.
Quando l'ultima stella si spegne nel cielo,
l'uomo adagio prepara la pipa e l'accende.
VOCI LIBERE - 1 - Ho dato poesia agli uomini
VOCI LIBERE - 1 - Ho dato poesia agli uomini
2024-09-20 18:58
2024-09-20 18:58
Array() no author 82229
Rivista letteraria, daniela-bianco,

- La nicchia - numero 107 - Il pettirosso nel linguaggio poetico di Emily Dickinson
- La nicchia - numero 106 - Il fuoco di Rosaria Ragni Licinio
- La nicchia - numero 105 - “le parole mi balzano fuori come leoni/ dalla prigione della boccaˮ
- La nicchia - numero 104 - Amok, romanzo breve e perfetto
- La nicchia - numero 103 - VALENTINA MELONI E' - SECONDO NOI - TRA LE PIU' IMPORTANTI CONOSCITRICI E TRADUTTRICI DI EMILY DICKINSON
- La nicchia - numero 102 - Breviario antalgico di Alessandro Camilletti
- La nicchia - numero 101 - C'è un'urgenza esplosa! Accaduta
- La nicchia - numero 100 - Dare fuoco al fuoco
- La nicchia - numero 99 - “Perché è nell’impossibile che sta la realtà”
- La nicchia - numero 98 - Il posto delle bacche
- La nicchia - numero 97 - All'uomo che sgrana il suo libro tra gli uccelli!
- La nicchia - numero 96 - Io nasco libero!
- La nicchia - numero 95 - Widad Nabi: il corpo delle ferite, l’esilio, l’amore per la vita
- La nicchia - numero 94 - La nuova silloge di Valeria Di Felice: Il giallo del semaforo
- La nicchia - numero 92 - Emily Dickinson tradotta da Nanita!
- La nicchia - numero 91 - La mia voce soccorrerà il loro grido
- La nicchia - numero 90 - Disregolazioni di Valeria Cartolaro
- La nicchia - numero 89 - Versi inediti tra le mie mani. In dialogo con Patrizia Antonicelli
- VOCI LIBERE - 8 - TUTTA L'ITALIA LETTERARIA NE E' AL CORRENTE
- La nicchia - numero 88 - “È tornata./ Che cosa?/ L’umana ferociaˮ
- La nicchia - numero 87 - L'albero della vita
- VOCI LIBERE - 7 - Essere dentro al tempo: lettere di Julio Cortázar
- La nicchia - numero 86 - Rimango poeta. Libero. Sempre
- La nicchia - numero 85 - In cerca dell’uomo nuovo
- La nicchia - numero 84 - Il fuoco ci esplode dentro!
- La nicchia - numero 83 - CHE COS’È LA VERITÀ (Spigolature da Racconti dall’Ohio di Sherwood Anderson)
- La nicchia - numero 82 - L'ispirazione è un'attesa
- La nicchia - numero 81 - Simone Cattaneo, come Cesare Pavese, Gabriele Galloni e Lorenzo Pataro…
- La nicchia - numero 80 - Scrivere per dissipare un destino e amarne un altro
- La nicchia - numero 79 - LIBERI TUTTI
- La nicchia - numero 78 - "quando Marzo è appena arrivato/ un colore si distingue là fuori"
- La nicchia - numero 77 - A PROPOSITO DI SANGUE DI CANE DI VERONICA TOMASSINI
- VOCI LIBERE - 6 - "Dovevo arrivare all’aurora"
- La nicchia - numero 76 - Questo suo continuo ‘cercarsi’ e ‘nascondersi’.
- La nicchia - numero 75 - "Se si pulissero le porte della percezione, ogni cosa apparirebbe all’uomo come essa veramente è: infinita"
- La nicchia - numero 74 - Sono intere notti che vivo come i gatti
- VOCI LIBERE - 5 - IMPROVVISI. La poesia di Franco Antonicelli
- La nicchia - numero 73 - Poesia e destino
- La nicchia - numero 72 - “Se voi sarete quello che dovete essere metterete fuoco in tutto il mondo”
- La nicchia - numero 71 - Dedica sotto falso nome
- La nicchia - numero 70 - LE STANZE. Poema del tempo che non passa
- VOCI LIBERE - 4 - L'esilio dell'inferno
- La nicchia - numero 69 - Ritrovare l’oro del mondo – Nota a "Tutto l’oro del mondo" di Guglielmo Aprile
- Appello a tutti i poeti: salviamo la Libreria Popolare di Via Tadino!
- La nicchia - numero 68 - “Alle montagne succedono le montagne. Ovunque si vada, non ci sono che montagne”
- La nicchia - numero 67 - "Monologo del sopravvissuto"
- La nicchia - numero 66 - Lezioni di letteratura
- VOCI LIBERE - 3 - L’immaginazione del cuore
- La nicchia - numero 65 - "per me sola innalza un canto"
- La nicchia - numero 64 - “Io posso fare di te torto o ragione a mio talento”
- La nicchia - numero 63 - Voi soltanto potete udire e vedere
- La nicchia - numero 62 - "guardare insieme la vipera cantare." Su una poesia di Alessandra Corbetta
- VOCI LIBERE - 2 - "siamo noi che cominciamo a vivere nei vostri sguardi"
- La nicchia - numero 61 - Luis Cernuda, il sangue e la polvere
- La nicchia - numero 60 - "Su fondamenta instabili", di Davide Morelli
- La nicchia - numero 59 - Ottobre è tempo d’amici
- La nicchia - numero 58 - Van Toorn e Holzhaus: i paesaggi dell’amore nella poesia nederlandese
- La nicchia - numero 57 - …Una poetessa totalmente poetessa, in ascolto di tutte le cose …
- VOCI LIBERE - 1 - Ho dato poesia agli uomini
- La nicchia - numero 56 - LETTERA A MIA MADRE
- La nicchia - numero 55 - UNA CORRISPONDENZA PRIVATA (E FAVOLOSA)
- La nicchia - numero 54 - Dai Wangshu, “Il poeta del vicolo nella pioggia”
- La nicchia - numero 53 - VALENTINA MELONI, IMPERTERRITA TRADUTTRICE DI EMILY DICKINSON. UNA NUOVA POESIA, IN ATTESA CHE NE FACCIA UN LIBRO!
- La nicchia - numero 52 - Il passaggio della fiamma
- La nicchia - numero 50 - Le geografie del coraggio: un invito alla lettura della poesia araba
- La nicchia - numero 49 - Jane Hirshfield - una poesia tradotta da Valentina Meloni
- La nicchia - numero 48 - Sandro Penna: la fragilità e il malessere di un grandissimo poeta italiano
- La nicchia - numero 47 - Del matrimonio del cielo e dell'inferno
- La nicchia - numero 46 - “Quasi niente”: l’ultimo romanzo di Valentino Ronchi
- La nicchia - numero 45 - La poesia è qualcosa di conviviale … Chiede una comunità – è un rito comunitario. È un donare. È sempre un dono… a se stessi, e a chiun
- La nicchia - numero 44 - Miguel Angel Bustos: si può uccidere il poeta, non la poesia
- La nicchia - numero 43 - Emily Dickinson tradotta da Valentina Meloni
- La nicchia - numero 42 - LETTERA A MIA MADRE
- La nicchia - numero 41 - Ci siamo affidati alla poesia, vocati a un destino
- La nicchia - numero 40 - Michele Nigro ci racconta "Carte nel buio"
- La nicchia - numero 39 - “…Lì non si muta. Lì non si prega…”
- La nicchia - numero 38 - La parola-parabola di Nickole Brown
- La nicchia - numero 37 - ECCEZIONALE! CRISTINA CAMPO E I POETI CONTEMPORANEI
- La nicchia - numero 36 - "Versi d’amore erotico per Natalie Zumab" di Mario Esposito
- La nicchia - numero 35 - “Tutto è determinato da forze sulle quali non abbiamo alcun controllo"
- La nicchia - numero 34 - Le ultime poesie di Giovanni Peli
- La nicchia - numero 33 - Malizia Christi
- La nicchia - numero 32 - L'anima è altrove
- La nicchia - numero 31 - VALENTINA MELONI TRADUCE LA POESIA DI MUNIR MEZYED
- La nicchia - numero 30 - Terramadre
- La nicchia - numero 29 - Una poesia di Robinson Jeffers tradotta da Daniele Gigli
- La nicchia - numero 28 - Le idee degli altri
- La nicchia - numero 27 - Caro Davide
- La nicchia - numero 26 - Alfonsina Storni (1892-1938) – la negazione del mare
- La nicchia - numero 25 - La poesia è infinita. Così capita di incontrare il brasiliano Murilo Mendes
- La nicchia - numero 24 - Guardami, sono un cristallo
- La nicchia - numero 23 - DIVENTARE CHIODI IN 350 POESIE
- La nicchia - numero 22 - Il bianco è un colore che ha molto a che vedere con la letteratura
- La nicchia - numero 21 - Oop, oop
- La nicchia - numero 19 - "Tre donne" di Sylvia Plath alla BBC
- La nicchia - numero 18 - Sandro Bonvissuto racconta "Un'isola", di Giorgio Amendola
- La nicchia - numero 17 - Louis Zukofsky, l’ossessione della parola
- La nicchia - numero 16 - Tradurre per non tradire
- La nicchia - numero 15 - Se una porta non viene chiusa, aldilà, c’è sempre un altrove.
- La nicchia - numero 14 - Siamo tutti nati dalla penna di Fernando Pessoa
- La nicchia - numero 13 - L’indifferenza è inferno senza fiamme
- La nicchia - numero 12 - L’eredità delle spine. Lettera a Salvatore Toma
- La nicchia - numero 11 - "IO SONO IL VETRO, IL VARCO, IO SONO IL VOSTRO POETA DI FONDO” - La poetica del Vuoto e del Sacro di CLAUDIA RUGGERI
- La nicchia - numero 10 - Confucio, Ezra Pound e il Lao Zi
- La nicchia - numero 9 - Alejandra, io t’invoco dall’ombra!
- La nicchia - numero 8 - Su un incipit di Consolo (che vale più di un libro). Con quella “e” Consolo ritrova la sua terra, la sua gente, e la imbeve di poesia
- La nicchia - numero 7 - Lettera
- La nicchia - numero 6 - Provate a leggere Antonia Pozzi!
- La nicchia - numero 5 - Editoriale: Un chiarimento: in risposta all’amico-poeta-attore-regista Franco Acquaviva
- La nicchia - numero 4 - Noi poeti siamo antiche divinità
- La nicchia - numero 3 - Cristina Campo, poetessa immancabile
- La nicchia - numero 2 - Ci vuole un alchimista come McCarty
- La nicchia - numero 1 - Pieni di stelle e canto
- La nicchia
- La nicchia
- @bigail
- Farsi la guerra per amore
- Noi viviamo definitivamente
- Il Carteggio Rilke-Pozzi, storia di redenzione e riscatto
- Lettera aperta ad Andrea Temporelli
- Il poeta è un folle disadatto. Con i suoi versi incendia
- Mi rialzo e resisto e combatto e amo
- Arrivederci
- Scrivo per sovvertire il mondo
- Salotto Baudelaire
- Poesia
- Un patto è stabilito per inscenare un sovvertimento
- Racconto
- Ottanta poetesse per Cristina Campo
- Si scrive sempre per dissipare un destino
- Libertà! Libertà! Libertà!
- Super flumina Babylonis
- Trafitto dalla sprezzatura di Cristina Campo
- Io sono letteratura
- A quale desco mi siederò domani?
- Non vendersi mai
- Su una poesia di Rita Stanzione
- Il poeta è solo
- Fondane poeta
- L'esilio di un poeta
- La fraternità nascosta della poesia
- Sulla poesia di Dora Laera
- Farsi la guerra per amore
- Non si può fare sempre quello che si vuole
- Si scrive per dissipare un destino
- Memento audere semper
- "Bastardo", un racconto di Giorgio Anelli
- L'altra faccia della letteratura
- Simone Cattaneo
- Una poesia corsara, unica nel suo genere
- Poeta e scrittore

La nicchia - numero 107 - Il pettirosso nel linguaggio poetico di Emily Dickinson
Dove la lingua diventa possibilità e il silenzio diventa significato
2025-12-10 21:59:38
2025-12-10 21:59:38

La nicchia - numero 106 - Il fuoco di Rosaria Ragni Licinio
Versi che non spariranno nella nebbia
2025-11-25 22:10:24
2025-11-25 22:10:24
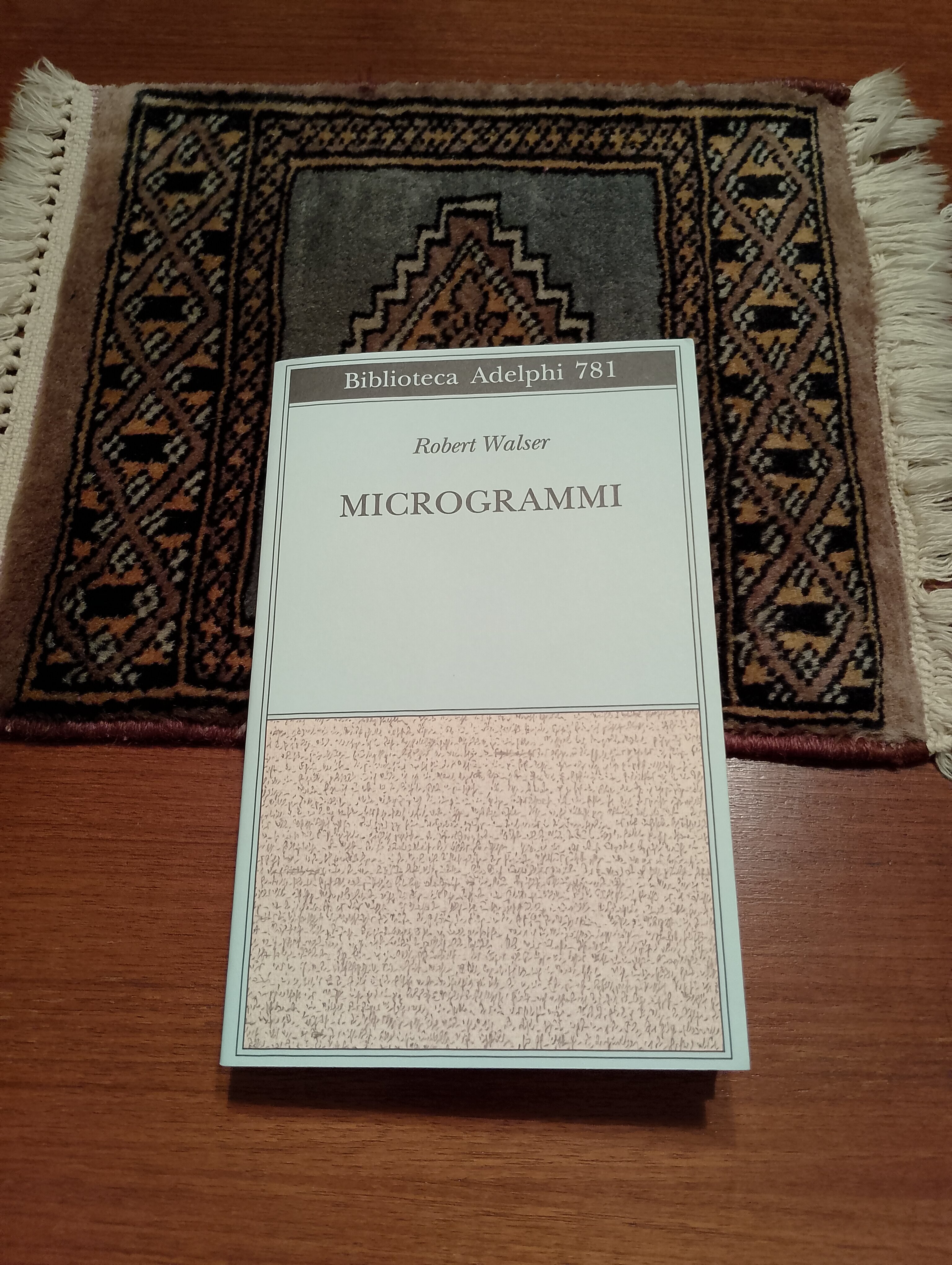
La nicchia - numero 105 - “le parole mi balzano fuori come leoni/ dalla prigione della boccaˮ
"sapere così tanto e aver visto tanto e/così niente, così niente dire."
2025-11-14 18:37:00
2025-11-14 18:37:00
SOCIAL
CONTATTAMI
INDIRIZZO
CS ©
