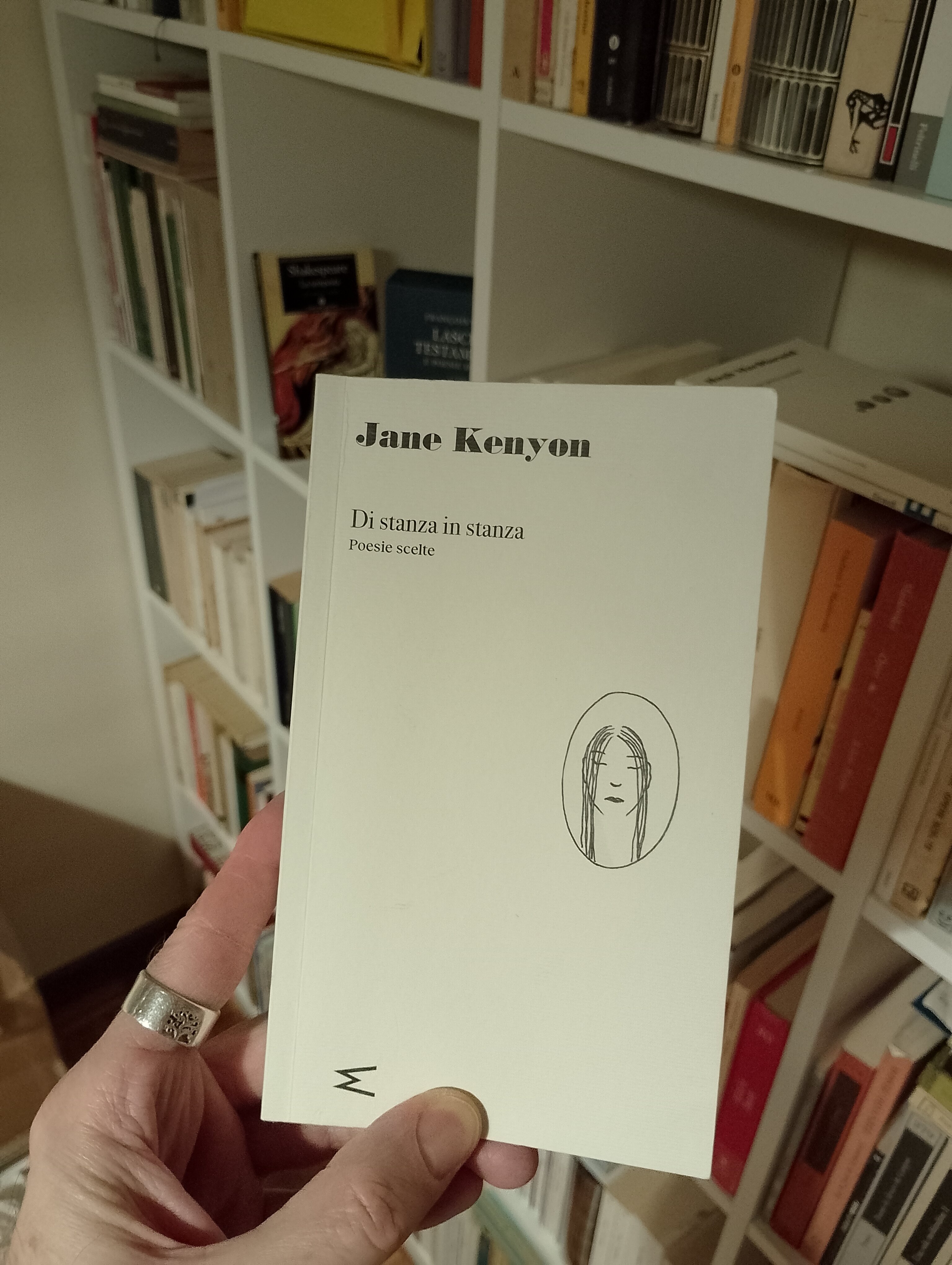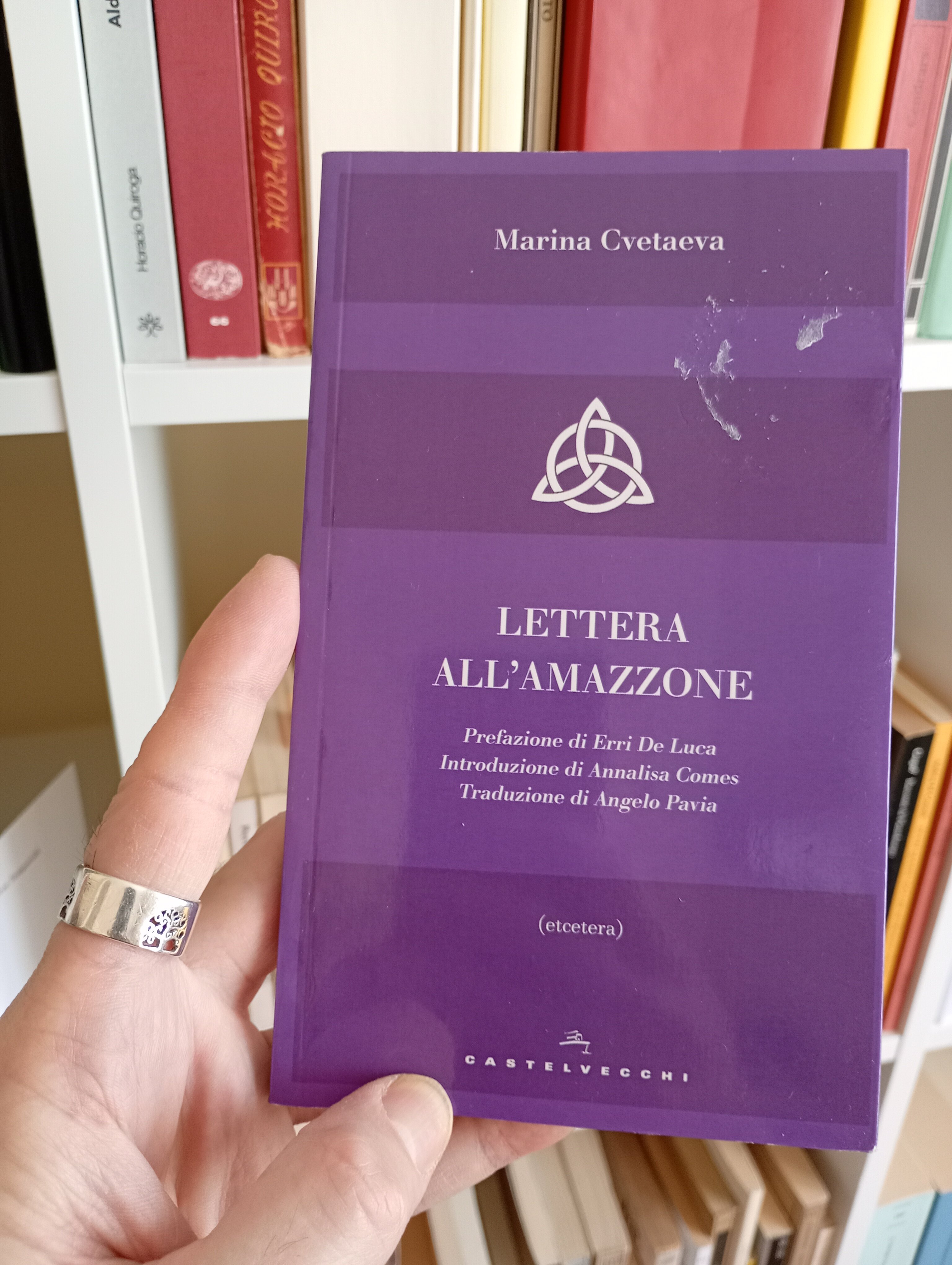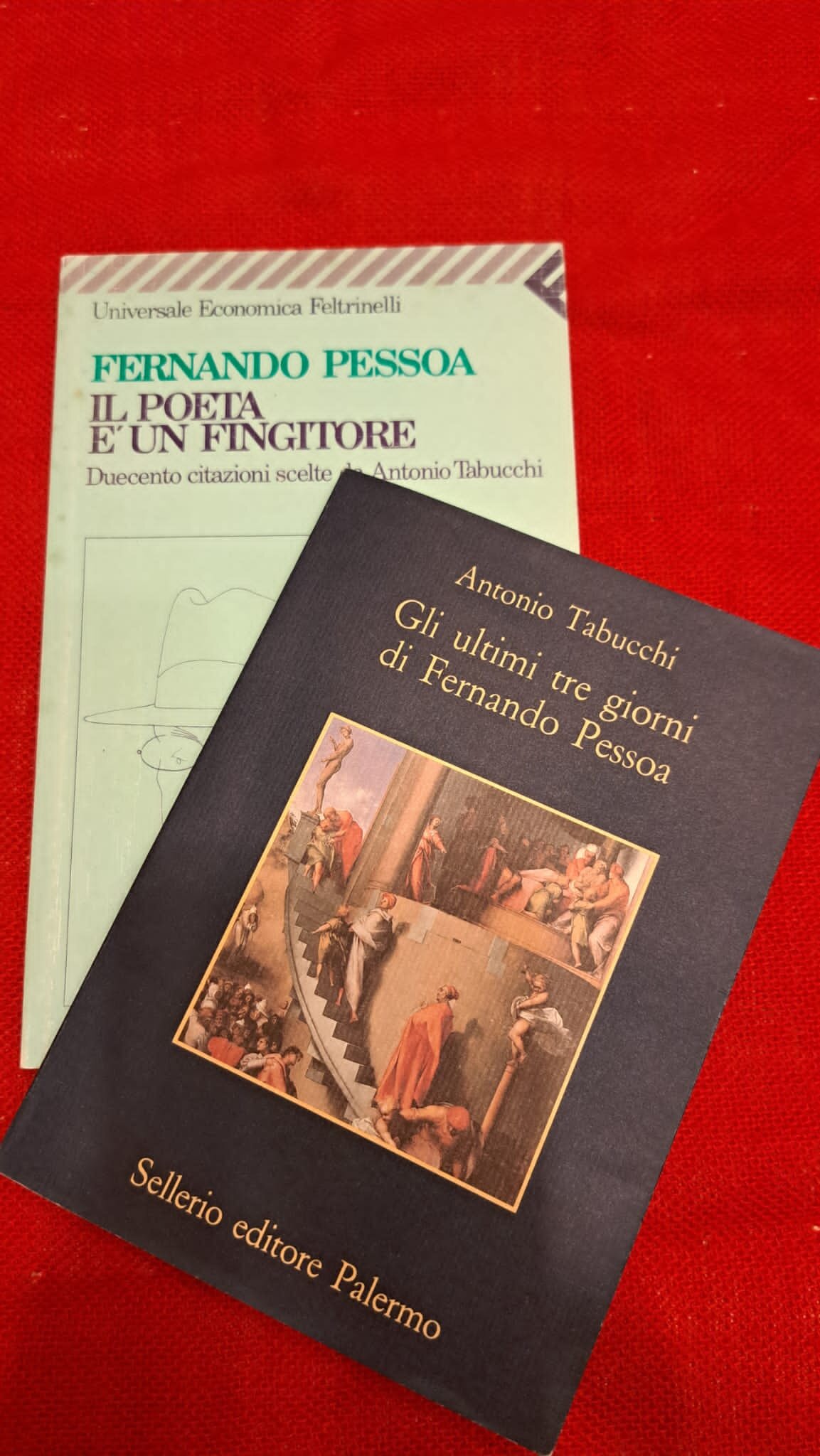È un libro corposo quello di Jane Kenyon.
Meno male. Abbiamo bisogno di «tanta» poesia, a mio avviso; di poesia bella che esondi da tutte le parti del mondo.
Quello di Jane Kenyon è un libro di cui mi fa dono Fabrizia Sabbatini, la curatrice. Un libro delle edizioni Pangea/Magog. Un libro di poesie scelte, tradotte da Davide Brullo e da Sabbatini, appunto.
Perciò la ringrazio, aprendo (come mio solito) il libro a caso e leggendo questa poesia meravigliosa:
Stagione del fango
Qui in purgatorio la terra brulla
si vede, a parte gli antri ombrosi
dove impera la neve.
Eppure, ogni giorno
un altro animale fa ritorno:
un passero, poc’anzi un’assonnata vespa;
e, al vespero, la puzzola
sbuca dalla tana,
ansiosa di incontrare simili e prede…
Il pavimento della legnaia
esala gelo,
e presto i primi germogli
di asparagi gemmeranno,
le dita di Lazzaro…
Le ferite dischiuse della Terra ‒ dove l’aratro
ha solcato il terreno in novembre ‒
devono essere appianate; alcune irrorate
di semi, e tutte obliate.
Ora il picchio muratore disdegna la sugna,
riprende la sua dieta di mosche, e
la rete, flaccida e unta, si può
smantellare.
Lungo il gradino della veranda
il croco si prepara a un’euforia
di porpora, ma al momento
tiene a freno la lingua…
Ciò che mi colpisce (oltre alla lingua del croco) sono queste “ferite dischiuse della Terra (…) che devono essere appianateˮ. Cioè, che devono in qualche modo essere superate, rimosse. Come se bisognasse andare a pari. Proprio come se nuovi semi fecondassero il terreno, sempre e forse per un nuovo inizio. Quasi scordando che la ferita ci sia mai stata, e che l’offesa venga abbandonata, dimenticando appena.
Giorgio Anelli